|
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Di Django Reinhardt s'è raccontato (qui e altrove)
praticamente tutto. Per chi volesse ripassare la sua vicenda...
 di Giordano Montecchi 18 gennaio 2010 di Giordano Montecchi 18 gennaio 2010
La storia è di quelle che fanno palpitare: avventura e sventura mescolate
insieme, di quelle storie che non basta un film per raccontarle. Perché è vita
vera, sofferenza, passione, sogni, miseria, fortuna, genio e sregolatezza.
Insomma: Django Reinhardt. Era il 23 gennaio di cent’anni fa. A Liberchies,
qualche centinaio di anime poco a nord di Charleroi, Belgio, faceva un freddo
cane. Appena fuori dal villaggio da qualche giorno c’era una carovana di
zingari, cinque o sei roulottes malandate, coi loro cavalli smagriti, i falò per
scaldarsi, e, al centro, una piccola tenda da circo. Quel giorno, in una delle
roulotte, Laurence Reinhardt partorì un maschietto. Laurence era così scura di
pelle da essere soprannominata «Negros». Era l’acrobata del circo ed rimasta
incinta di Jean Vées, acrobata anche lui e, quando poteva, musicista: chitarra,
violino, un po’ di tutto. Lei però non volle saperne di sposarlo. Il bambino si
chiamò Jean-Baptiste, ma presto gli fu affibbiato l’immancabile soprannome:
Django.
IL BANJO A DODICI ANNI. La carovana viaggò ancora molto. Girovagarono per
l’Italia, poi furono in Algeria e infine si fermarono alla periferia di Parigi.
Sua madre gli regalò un banjo, e a dodici anni Django accompagnava già suo padre
e suo zio che si esibivano al caffé del mercato delle pulci di Clignancourt,
poco fuori Parigi. Django era bravo, molto bravo, suonava la chitarra con una
grinta e una velocità da lasciare a bocca aperta. A diciotto anni aveva già
registrato qualche traccia, aveva la sua piccola fama, ma era e restava uno
zingaro e ogni notte tornava a dormire nella sua vecchia roulotte. La sua
seconda nascita avvenne nel 1928 e fu tragica. Era ottobre, il 26. Jack Hylton,
leader di un’orchestra alla Paul Whiteman piuttosto famosa, gli offrì di entrare
nella sua band per una tournée in Inghilterra. Era fatta!
Forse quella sera Django era eccitato, fatto sta che rovesciò la candela accesa
e i fiori di celluloide da vendere l’indomani davanti al cimitero presero fuoco
e in un baleno la roulotte fu avvolta dalle fiamme. Bella Baumgartner, la sua
compagna, se la cavò con poco, ma Django riportò ustioni gravissime sul lato
destro del corpo e alla mano sinistra. Diciotto interminabili mesi di ospedale,
e alla fine, mignolo e anulare della mano sinistra rimasero paralizzati. I
medici furono unanimi: la sua carriera di musicista era finita. Ma non sapevano
con chi avevano a che fare. Perché da quel rogo di miseria ed emarginazione,
qualcosa che ben conosciamo ancora oggi, era nato Django Reinhardt, il dio
zingaro della chitarra. Dio, perché nessun essere umano avrebbe potuto essere
così testardo, inventarsi un modo di suonare con solo due dita e diventare un
virtuoso impressionante, rivoluzionando la tecnica e il destino della chitarra.
La carriera fu sfolgorante. Incontrò il suo alter ego in Stéphane Grappelli,
violinista tanto per bene quanto Django fu sempre imprevedibile, sbruffone,
spendaccione. Col loro celeberrimo Quintette du Hot Club de France furono i
protagonisti assoluti del trapianto del jazz in Europa, con Monsieur Grappelli
perennemente imbarazzato per le figuracce cui lo costringeva Django: analfabeta
vero, per il quale un contratto era solo carta; nomade nell’anima, bisognoso
ogni tanto di sparire per tornare alla sua roulotte e alle sue radici. Django
era fin troppo «fenomeno» per accodarsi a una musica altrui qual era in fondo il
jazz. Andò in America, ma il suo idolo Duke Ellington fu una delusione: tutto
troppo ordinato, ufficiale, per lui che non volle mai leggere una nota di
musica. Django era un sinti, che in Francia sono detti manouche, ricchi come
tutte le etnie zingare di una loro tradizione musicale tutta chitarre e violini.
Django la «contaminò» e nacque il jazz manouche, jazz portatile: chitarra e
violino solisti, niente batteria ma due chitarre e contrabbasso per la pompe,
così si chiama quel ritmo indiavolato che ti scortica e sale su dalle piante dei
piedi.
INCIDENTE PITTORESCO Curioso sfogliare le pagine di allora. Per André Hodeir,
grande jazzologo, Django non era jazz, ma solo un «incidente pittoresco». Ma
girate oggi per dischi, o per locali. I gruppi di giovani e giovanissimi,
calamitati da questo modo sfrenato di scoparsi la chitarra, sono una schiera e
gli scaffali, quelli che restano, pieni di questa musica, un po’ jazz un po’
world music, con protagonisti dai nomi così inesorabilmente diasporici: Bireli
Lagrène, Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt ecc. Hodeir toppò,
ma non Eric Hobsbawm, che nascosto dietro lo pseudonimo di Francis Newton nel
1959 pubblicava The Jazz Scene, magnifica storia del suo oggetto amato. Dice
Hobsbawm: «è significativo che Reinhardt sia fino ad ora il solo europeo che
abbia conquistato un posto nell’Olimpo del jazz... ed è significativo che si
tratti di uno zingaro». Perché insistere su quel «significativo»? Perché un
grande storico come Hobsbawm aveva capito che il destino del jazz non era quello
di essere solo la musica dei neri. Il jazz era l’annuncio che una nuova musica
alzava la voce: la musica di quelli che il «primo mondo» ha sempre ignorato o
odiato. Django è storia di adesso.
 19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00 19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00
Via Mecenate, 35 - Roma (mappa)
MOSTRE
Terre sospese
fotografie di Stefano Montesi
Il popolo del vento
pannelli sulla storia di rom e sinti
Esposizione di oggetti di artigianato
22 gennaio 2010 ore 17.00
tavola rotonda
Artigianato tradizionale e prospettive di lavoro delle popolazioni rom e
sinti
Partecipano:
Paolo Ciani Comunità di Sant’Egidio
Marco Brazzoduro Sapienza Università di Roma
Gianluca Staderini Popica onlus
Fulvia Motta C.R.S. Caritas Diocesana di Roma
Stefano Montesi Fotografo
Sono invitati rappresentanti della Regione Lazio e delle Comunità di Roma
ore 19.00
Dimostrazioni di tecniche di lavorazione del rame e artigianato rom
ore 20.00
Spogliati dai pregiudizi… vesti gipsy
sfilata della collezione primavera-estate 2010
Antica sartoria rom accompagnata dalla musica del Quartet Gipsy
ore 20.30
rinfresco
ore 21.00
concerto Quartet Gipsy
ritmi balcanici e orientaleggianti, doine e sirbe tradizionali romene,
canzoni gitane dell’area mediterranea
Marian Serban cymbalon - Aristide Bucor violino
Albert Mihai fisarmonica - Isak Tanasache contrabbasso
Ingresso libero
L'appuntamento su
Facebook
Da
Aussie_Kiwi_Roma
LIKE WATER/SAR O PAJ - antologia inglese/romanés di poemi di
donne rom - Curata da Hedina Tahiroviae Sijercic, pubblicata nel 2009 da
Kafla InterContinental,
www.indianwriters.org
"Molto spesso noi donne siamo state escluse dalle nostre comunità, e sotto
i nostri leader maschi non è facile spiegare le nostre menti, esprimere le
nostre idee e fare arte." Questo sentimento è ciò che ha ispirato Hedina
Tahiroviae Sijercic a compilare il primo volume di poesie di donne rom. Il
titolo dell'antologia è preso da un poema di Papusza, una delle più liriche ed
emotive scrittrici rom.
Le otto poetesse provengono da ambienti e paesi differenti, ma la maggior
parte ora risiede in Canada o Australia. Le loro poesie ricadono in quattro
categorie principali: autobiografia, lamento, aneddoti ed elogio alla natura.
La collezione inizia con i lavori della stessa Hedina Tahiroviae Sijercic.
Originaria di Sarajevo, in CV1 Hedina fornisce una storia poetica della
sua vita, tipica delle esperienze di molti Rom. Altre poesie, a volte tenere,
altre selvatiche, mostrano le difficoltà di un popolo spesso insultato, affamato
e senza documenti. Come piange in CV2, Naj amen papiri! Kai bizo papiri? Non
abbiamo documenti! Dove possiamo andare senza documenti?
Sarah Barbieux, originaria di Parigi, scrive della pena del nascondere la sua
identità zingara da bambina, ed a voce alta ricorda le canzoni che le
insegnavano i genitori. Julia Lovell, nata in Scozia, accenna alla
sterilizzazione e allo sterminio degli Zingari sotto il Terzo Reich. Gina
Csanyi-Robah, nata a Toronto, fornisce una narrativa in movimento sulla morte
della nonna in Dza e Devalesa meri phuri Dai/Goodbye NagyMama. Yvonne
Slee, nata in Germania, chiede alle altre donne rom di levarsi in piedi accanto
a lei nel mantenere viva la cultura rom. Le poesie della canadese Thais Barbieux
danzano attraverso la pagina con i mitici dragoni, principesse e cavalieri. Rasa
Lee Sutar, nata in Baviera, scrive sulla dignità di affrontare la persecuzione.
Lynn Hutchinson, che vive a Toronto, offre cinque poemi per suo padre. Le
incredibili immagini di good eye clenched/glass eye staring/ tears pouring
from both eyes/the living and the dead, e la descrizione delle bambole che
lui costruiva per lei, inghiottendo le loro verità con il suo ultimo alito,
turbano e sono memorabili.
A volte ogni poeta sale ai livelli che Papusza raggiungeva senza sforzi.
Nella sua poesia maledetta Phuv/Earth, Hedina Tahiroviae Sijercic mostra
al sui meglio la poetica rom, periodi lanciati, che redimono, universali. Sarah
Barbieux, in But Baxt Tuke/May you be lucky, dice Nashti davas tuke
mai but/ferdi murro orimos, mo swinto orimos.../I have been able to give you
nothing more than my wish, my sacred wish... Gina Csanyi-Robah ode o
Romano muzikako bashalipe/the Gypsy music forever playing... In Romane
phenja/Roma sisters, Julia Lovell usa tipiche immagini naturali zigane del
sole e della luna di grande effetto. Yvonne Slee in Cikni Tradicija/A little
tradition, scrive una bella poesia sula sua nonna Sinta che le insegna sulle
erbe e le bacche, seduta sotto una vecchia quercia. Thais Barbieux in O Drom
o kezhlano/The Silken Road descrive come il suo cuore danzi fuori dalla
prigione dei numeri su una strada di seta. Rasa Lee Sutar in Bistardino/Forgotten,
mette a confronto le farfalle col treno nero dei nazisti e Lynn Hutchinson
ispira poemi che mischiano la tradizione lirica popolare col realismo.
Questo importante libro rivela i pensieri e gli ideali di alcune donne rom
del nostro tempo. Sono lieta di aver visto le poesie in lingua originale, di
avvertire il loro ritmo che spesso si perde nella traduzione. Vorrei anche
vederne il seguito, presentare poetesse da tante altre terre.
Un'impresa insolita ed una lettura affascinante!
Janna Eliot, romaroadz@yahoo.co.uk
Da
Czech_Roma

Brno, 5 gennaio (CTK) - Ivona Parciova, dell'IQ Roma servis, ha detto ieri a CTK
che Rom cechi della comunità di Brno reciteranno questa settimana la love story
di un Romeo rom e una Giulietta bianca, basata sul famoso dramma di
William Shakespeare.
La performance intitolata "Romeo e Giulietta - Una Storia di Strada" [è stata
presentata] il 6 e 7 gennaio al teatro Reduta di Brno.
Il complesso rom trasformerà la famosa tragedia dei due giovani amanti delle
famiglie dei Capuleti e dei Montecchi, in una moderna love story di gente di
differenti gruppi etnici nella società attuale, ha aggiunto Parciova.
Saranno una parte importante dell'allestimento le "danze di strada"
presentate dal gruppo Danza il Cortile.
La performance è stata preparata nel quadro del progetto Attraverso la Danza
verso la Comprensione e la Tolleranza, tenutosi a Brno dallo scorso marzo.
Terminerà a giugno.
Lo scopo principale è di coinvolgere i giovani delle località socialmente
escluse in attività creative, e quindi mostrare loro come impiegare il loro
tempo libero in maniera positiva, ha detto Parciova.
"Volevamo mostrare che la musica e la danza possono connettere vari gruppi
etnici, e che unire gli interessi può migliorare la loro coabitazione," ha detto
l'educatrice Nela Zivcakova.
La performance teatrale è stata preparata da membri di IQ Roma servis di età
tra i 15 e i 18 anni, assieme ad altri bambini.
IQ Roma servis aiuta le famiglie e i bambini minacciati dall'esclusione
sociale, soprattutto Rom, a Brno.
Inoltre, il centro Drom Romany ed il Museo della Cultura Rom a Brno stanno
cercando di migliorare la situazione della locale comunità rom a Brno, che con
360.000 abitanti è la seconda città della Repubblica Ceca (10 milioni di
abitanti). Oltre 17.000 Rom vivono a Brno, secondo le stime degli esperti.
Copyright 2009 by the Czech News Agency (ČTK). All rights reserved.
Da NuovaSocietà.it
- di Eugenio Goria
Jazz manouche non è un'espressione molto familiare tra i non appassionati, ma
in realtà questa musica è ogni giorno sotto gli occhi di tutti.
Chi per esempio non si è mai fermato ad ascoltare almeno per un attimo le note
dei musicisti rom e sinti che facilmente si incontrano nel centro cittadino. Ci
possiamo forse dimenticare Johnny Depp in "Chocolat", quando prende la chitarra
e suona quel curioso pezzo che ci sembra di conoscere da sempre? Beninteso, non
tutti gli zingari suonano jazz manouche, ma è proprio da loro che negli anni
'30 nacque in Francia un linguaggio musicale che di lì a poco sarebbe stato
conosciuto e imitato in tutto il mondo, grazie alle celebri composizioni del suo
inventore Django Reinhardt.
Negli anni '30, prima dell'avvento delle leggi razziali, i gitani vagavano per
l'Europa, portandosi dietro un'antica tradizione musicale. La loro musica veniva
suonata con strumenti semplici e facili da portare in giro, essenzialmente il
violino e la chitarra; come ogni genere popolare essa è costituita da un
martellante ritmo binario sopra il quale suonano uno o più solisti. Quando
questo bagaglio di tradizioni giunse in Francia, dalle parti di Parigi, si
incontrò con la locale tradizione della "musette", un valzer popolare suonato
dalle orchestrine locali. Django Reinhardt, come molti altri zingari, appena
diciottenne si guadagnava da vivere suonando il banjo in una di queste
orchestrine; una sera, un incendio nella roulotte in cui viveva gli provocò
gravi ustioni che tra l'altro gli paralizzarono due dita della mano sinistra.
Sembra strano ma fu proprio in seguito all'incidente che Reinhardt, rifiutando
l'amputazione, iniziò a dedicare anima e corpo alla chitarra per trovare un
sistema che gli permettesse di suonare anche in quelle condizioni.
Fu in quegli anni che nacque il manouche. Nato dal'incontro tra la musica dei
gitani e la musette, teneva conto anche della grande popolarità di cui godeva lo
swing d'oltreoceano, così il nuovo genere fu un vero e proprio miscuglio di
queste tre sonorità. Solo una mente geniale, che non aveva che una vaga idea di
cosa fosse la composizione poté tirare fuori una musica che univa il ritmo
ossessivo delle canzoni tzigane con l'andamento sincopato dello swing. Anche
l'improvvisazione, come in tutto il jazz, ha un ruolo tutt'altro che marginale e
si articola su una ritmica fatta di accordi spesso diminuiti che in francese
gergale prende il nome di "pompe". Non avendo percussioni ovviamente la chitarra
ritmica deve guidare il solista nella sua esecuzione cercando il più possibile
di sostituire gli strumenti mancanti mediante una marcata linea di basso, e
questo è il tratto che più si discosta dalla tecnica dei jazzisti.
Django cavalcò l'onda del successo quando si unì al grande violinista Stephane
Grappelli con il quale incise i suoi brani più famosi come il "Minor swing" e "Nuages".
Ciò che colpiva di questi brani, e ancora adesso li rende inimitabili era la
squisita immediatezza, la primaria semplicità con cui sapevano parlare la lingua
di ascoltatori più e meno esperti. Ascoltare Reinhardt vuol dire riscoprire
suoni e immagini di una Francia pre bellica che sa di pastis e di ballerine in
decolleté, lasciarsi trasportare da un ritmo coinvolgente e affascinante come
tutti gli ibridi.
Il manouche non finì con la morte del suo inventore. Continuò con Stephane
Grappelli, il violinista che aveva suonato con Django i pezzi più famosi, e
progressivamente con altri jazzisti sempre più tecnici e specialisti, o che
quantomeno potevano avvalersi di più di tre dita nella mano sinistra. La tecnica
esecutiva e compositiva oggi è aumentata incredibilmente, ma la scarsa fantasia
insita nei generi popolari ferma in continuazione la mano ai musicisti di nuova
generazione che prima o poi sentono l'esigenza di confrontarsi con l'inventore
del manouche e in definitiva finiscono a riproporre i suoi pezzi. Certo un
contemporaneo come Biréli Lagrène ha un tocco più dolce, è più veloce e meno
ripetitivo, ma lui come altri tendono a perdere quella spontaneità originaria
che resta prerogativa del solo Reinhardt.
Ricevo da Marta Pistocchi
buon 2010 a tutti!
ecco l'occasione per prolungare i festeggiamenti, ascoltare e ballare buona
muzika nell'attesa del natale e del capodanno ortodosso, che ancora han da
venire! (ma soprattutto della prossima festa balcanica)
Muzikanti di Balval a Pregnana Milanese
5 gennaio 2010 Auditorium di via Varese 21
dalle ore 21
degustazione di piatti di diversi paesi
concerto di musica balcanica rom e danze gypsy fusion
organizzato dall'associazione La Sorgente e Di Più
vi aspettiamo
 Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.
9,50 E.
www.edizionierasmo.eu Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.
9,50 E.
www.edizionierasmo.eu
In mezzo ai capitoli del romanzo breve “Lungo la ferrovia” corrono le storie di
due incontri. Il primo - reale - è quello tra Gianluca Giunchiglia, pisano di
nascita ma livornese d'adozione, psicopedagogista in servizio presso l'Istituto
scientifico Fondazione “Stella Maris” di Calambrone (Pisa), e il bambino rom che
la sua struttura gli ha affidato tempo fa; il secondo – intensamente immaginato
– è quello che intreccia i destini di Gioni e Miluna, undicenni, due piccoli rom
cui la fantasia del Giunchiglia scrittore ha affidato il ruolo di protagonisti
nel libro che segna il suo esordio nel campo della narrativa.
Dal primo incontro, si sviluppa il secondo. Dentro l'invenzione letteraria che
insegue questi adolescenti attraverso le tantissime gamme della loro penetrante,
solare, inquieta vitalità, ci sono le impressioni, i ricordi, le riflessioni di
un “gagé” (termine che i rom usano per indicare noi italiani) che viene invitato
dalla famiglia di un piccolo zingaro all'interno di un “campo”. Capitò un 6
maggio, si festeggiava S. Giorgio. L'incontro si svolse «dentro un container
adibito a casa – scrive l'autore in una nota – dove questa famiglia vive. Era il
primo giorno della loro festa e grandi e piccini erano ben tenuti e vestiti con
gli abiti più belli che avevano. Mi hanno accolto con dolcezza, omaggiandomi
delle pietanze tipiche della loro cultura […] Pure le regole dell'igiene erano
rispettate, gli alimenti cucinati in contenitori usa e getta con posate di
plastica. All'esterno, nel “campo”, non vi erano immondizie sparse attorno,
contrariamente a quello che si può immaginare. Solo che vivono con un sistema
fognario danneggiato e mal funzionante che crea pozzanghere di acque nere a
cielo aperto. Le atmosfere però sono invidiabili; le musiche, il contatto con la
terra, sono tipiche di quel popolo, così molto attento alla natura...».
Luci e ombre. Le stesse che colorano i gesti, le parole di Gioni e Miluna. Ecco
perché la fantasia e la realtà risultano, tra queste pagine, sorprendentemente
sincrone, empatiche, parallele come le verghe del binario che appare nella foto
di copertina. Anche le luci e le ombre di quest'esistenza di frontiera osservata
con gli occhi dell'adolescenza corrono in parallelo. Ciò che affiora in
superficie è una penombra cangiante pronta in qualsiasi momento a diventare
sereno come anche a trasformarsi in tempesta; una specie di tramonto dalla luce
sorprendentemente nitida che consente di osservare tutto con chiarezza, anche le
contraddizioni, anche il doloroso attrito di bene e male, legalità e illegalità,
integrazione ed emarginazione, cultura e degrado. Giunchiglia sintetizza (e
spiega) questa realtà dalla valenza ossimorica con un verso di Holderlin: “Là
dove c'è pericolo, cresce ciò che salva”.
Pubblicato in marzo da Media Print Editore, subito dopo ristampato per i tipi
delle Edizioni Erasmo, “Lungo la ferrovia” si è aggiudicato menzioni speciali al
Premio Internazionale “S. Margherita Ligure – Franco Delpino”, al Premio
“Emozioni d'inchiostro” di Reggio Calabria, al Premio letterario “Viareggio
Carnevale”. A novembre è stato premiato da Alexian Santino Spinelli,
ambasciatore dell’arte e della cultura Romanì nel mondo e professore
all’Università di Chieti, per il secondo posto al Premio artistico
Internazionale “Amico rom”, sezione opere edite di narrativa.
Il libro è stato presentato al settembre pedagogico del Comune di Livorno e
diverse scuole secondarie di primo grado lo stanno adottando per i progetti
sull’intercultura.
Andrea Lanini (Giornalista)
“Lungo la ferrovia” è un romanzo breve, di facile lettura, scritto da un
pedagogista che ama la poesia, tanto da vincere dei premi. Un romanzo si sa è
una rappresentazione (fantastica) della realtà, l’immaginazione di eventi che
accadono nella mente dell’autore che li ha vissuti in altra forma e che li ha
approfonditi e analizzati in vari aspetti; cioè esso è un ideazione che riporta
però dei fatti conosciuti a fondo, dentro le loro dinamiche interattive che poi,
con l’ausilio della creatività, si trasformano in un’invenzione. Non faccio una
recensione all’opera letteraria, non sarei adatto. Ho letto il romanzo con una
visione pedagogica e traggo solo qualche considerazione.
L’argomento trattato è un tema d’indubbia attualità sociale e politica: il
problema rom che, pur esistendo da sempre, in questo periodo storico è
sviscerato dai media continuamente più nel male che nel bene, con ricadute che
considero importanti sul piano culturale. Ciò che mi ha colpito nel racconto non
è tanto il rapporto dei due protagonisti (Gioni e Miluna), la loro storia e la
loro amicizia, quanto le relazioni dei contesti in cui essa si sviluppa. I
contesti sono rappresentati dal gruppo dei pari, dalla scuola e dagli adulti che
in essa vi lavorano, dal “campo” rom, dalla comunità vicina al “campo” rom. In
questi contesti l’autore descrive una fitta rete di interazioni fatte da
accettazione e rifiuti. Non emerge nessun tentativo d’integrazione nel suo
significato pieno, forse un atteggiamento di questo tipo lo si ritrova
nell’autista dello scuolabus, che però ha un ruolo marginale per poter diventare
la figura di riferimento per l’integrazione.
I due ragazzi protagonisti, come tutti i ragazzi della loro età, sono in una
fase di costruzione della propria identità personale e sociale, per cui hanno
bisogno sperimentare ruoli, realizzare esperienze mediante l’incontro con l’
“altro”, di seguire esempi e modelli. Essi manifestano bene questi bisogni nel
corso della loro vita quotidiana e nel rispetto delle differenze di genere:
Gioni li esprime con molta più energia di Miluna e, proprio per le differenze
individuali, reagisce con la fuga a quello che percepisce come rifiuto.
L’esempio, il modello buono, il riferimento educativo è il nonno (nemmeno il
padre) che è l’unico ad esprimergli un progetto di vita, è colui che stimola il
nipote a compiere la programmazione del suo futuro. Ma è una figura sola, che
sta nel “campo” rom (e questo non è un caso!) e con un debole aggancio (la
signora amica) nella comunità sociale. Poco per un processo evolutivo, per un
cambiamento sociale.
Il romanzo descrive una realtà vera che una società civile come la nostra,
democratica, che si basa sul principio della non discriminazione, non può più
trascurare e rimandare oltre.
L’autore con questo suo primo romanzo offre molti spunti di riflessione e ci
spinge ad avviare un progetto serio verso l’integrazione delle culture.
Giuseppe Rulli (Pedagogista)
Mi scuso per il ritardo della segnalazione, il concerto è
stasera alle 20.00

Porrajmos nel linguaggio Rom significa “divoramento” e indica la persecuzione e
lo sterminio che il Terzo Reich attuò durante la Seconda Guerra Mondiale
uccidendo oltre 500 mila esseri umani. Nel 1936, alla vigilia dei giochi
olimpici di Berlino, Hitler decide che la città deve essere ripulita. La
politica razzista dei nazisti porta alla costruzione di un campo di
concentramento a Marzahn, dove vengono internati centinaia di Rom e Sinti.
La persecuzione di Rom e Sinti è l’unica, unitamente a quella ebraica, a
essere dettata da motivazioni pseudo-razziali, ma la tragedia delle popolazioni
sinte e rom non si conclude con la fine della Guerra: la Repubblica Federale
Tedesca infatti, riconoscerà la loro persecuzione molto tempo dopo, concedendo i
risarcimenti con grandissimo ritardo.
Francesco Lotoro ha cercato di ricostruire un importante tassello della
letteratura concentrazionaria aggiungendo all’opera da lui curata,
l’Enciclopedia discografica KZ Musik pubblicata dalla Musikstrasse di Roma
giunta al dodicesimo CD-volume, l’intero corpus musicale creato da Sinti e Rom
nei campi di sterminio durante il Secondo Conflitto Mondiale. Il risultato di
questa prestigiosa opera di ricostruzione sarà presentato sabato 12 dicembre
all’Auditorium dell’Assunta a Trinitapoli alle ore 20. ‘Prendi un violino e
suona’ è il titolo dato alla conferenza concerto alla quale prenderanno parte
oltre allo stesso Lotoro, l’assessore al Mediterraneo della Regione Puglia,
Silvia Godelli, il Sindaco di Trinitapoli Ruggero Di Gennaro, il Commissario
straordinario di Margherita di Savoia Rachele Gandolfo, il Dirigente scolastico
della Scuola Media Giuseppe Garibaldi di Trinitapoli Anna Maria Trufini, il
musicista Rom slovacco Milan Godla.
Il programma del concerto comprende canti creati a Belzec, Auschwitz, Chelmno
e nei campi di lavoro forzati aperti dai nazisti in Slovacchia.
“Il lavoro di recupero della musica creata dal popolo Romanì nei Lager è
stato molto più complesso di altre parallele produzioni concentrazionarie. Ciò
perché trattasi prevalentemente di musica trasmessa oralmente e conservata
pressoché intatta nella loro vita quotidiana e nella memoria collettiva.” Spiega
il professor Lotoro. “Molti di questi canti arrivano a noi attraverso diversi
modi di esecuzione che variano (a volte anche in modo significativo) da
villaggio a villaggio. Per esempio, Andr’oda taboris cantato a Dhlè Stràze ha
piccole differenze rispetto a quello cantato a Zehra, anche se il testo
coincide”.
Da quanto tempo lavora a questo progetto di recupero della musica dei Rom
e dei Sinti nei lager?
Lavoro a questo particolare filone delle mie ricerche da circa 10 anni; ho
dovuto attendere la pubblicazione del dodicesimo volume dell’Enciclopedia KZ
Musik per dedicarmi con particolare attenzione negli ultimi 12 mesi alla musica
di Rom e Sinti nei lager nazisti, convogliando qui in Puglia alcuni tra i più
validi strumentisti del repertorio Rom come Milan Godla, Marian Serba e Ion
Stanescu, noleggiare ottimi strumenti musicali adatti a tale repertorio come un
grande cimbalom, il tarogato (un particolare clarinetto a forma conica) e una
gamma enorme di flauti e recorders.
Quale è la particolarità di questa musica?
Trovo questa musica molto più “permeabile” della situazione umana nei campo.
Mi spiego; tenendo sempre presente la diversa tipologia dei campi (internamento,
transito, concentramento) e lo stato di cattività più o meno flessibile (ebrei,
detenuti politici, polacchi, civili o militari), la produzione musicale degli
Ebrei a Theresienstadt, dei polacchi ad Auschwitz e Mauthausen, dei frati
benedettini e francescani a Dachau (giusto per fare alcuni esempi) è sempre
“filtrata” dal gusto mitteleuropeo dell’epoca, dall’attenzione alla partitura,
scritta meticolosamente anche su supporti fragili (carta-musica sporca, carta
igienica incollata a strati), dalla giusta strumentazione. .Nella produzione
Romanì, invece, il campo “entra tutto” nella musica, il dolore si fa
musicalmente più intenso senza mediazione; la musica sembra essere l’espressione
più autentica dello stato di abbandono che hanno particolarmente sofferto i Rom
nei campi.
Come dire, la musica di Sinti, Roma, Kalè e di altre famiglie del popolo
romanes è immediata, colpisce di primo acchito, non si fa andare a cercare; e va
suonata lasciando il musicista e il cantante, in un certo senso, liberi di
esprimersi, ricavare l’improvvisazione del momento. Non possiamo neanche
immaginare quanta musica dei Rom abbia respirato, fianco a fianco, con quella
ebraica.
Nei giorni più tristi non solo per l’Europa ma per l’intera civiltà umana,
Ebrei e Rom hanno cantato e suonato l’ultima musica prima che la peggior sorte
si accanisse su questi due popoli dando origine alla catastrofe (la Shoah) e al
divoramento (il Porrajmos).
Lucilla Efrati
VareseNews
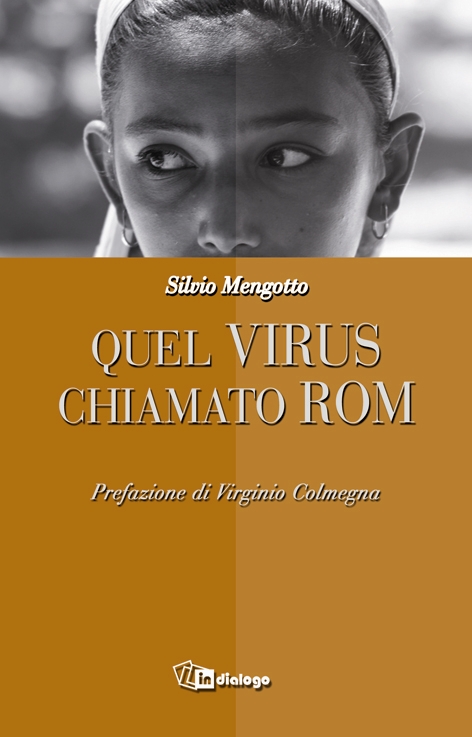 Un libro sui pregiudizi verso i popoli nomadi, costruito a partire da un viaggio in un campo rom. Con la prefazione di don Colmegna, presidente della Casa della Carità Un libro sui pregiudizi verso i popoli nomadi, costruito a partire da un viaggio in un campo rom. Con la prefazione di don Colmegna, presidente della Casa della Carità
È in libreria Quel virus chiamato rom, libro-diario di Silvio Mengotto, edito dalla cooperativa culturale In dialogo di Milano, dove con parole e fotografie si racconta il lungo viaggio compiuto, giorno dopo giorno, in un campo rom alla periferia di Milano. Un giorno, parlando con una donna, l’autore del libro rimase colpito da una frase: «Noi continuiamo nel bene e nel male a parlare di rom, mentre abbiamo bisogno di parlare con i rom». Da questa intuizione nacque l’idea di scrivere un diario dell’esperienza vissuta accanto ai nomadi nell’arco di due anni, sino allo sgombero definitivo del campo, eseguito freddamente e senza una reale alternativa. Pagine scritte dal vivo, per sconfiggere il disagio e persino la paura della presenza degli zingari nelle nostre città. Pensieri, riflessioni, emozioni, dubbi, interviste che hanno memorizzato le relazioni significative, aprendo gli occhi del cuore su un mondo rom, ancora troppo sconosciuto. Un diario che si è trovato a costruire il ponte della relazione non per parlare dei rom, ma dopo aver parlato e comunicato con loro.
Scrive l’autore: «Tra i cinque sensi dell’uomo quello della vista esercita un’autorità che stordisce, molto più forte dell’udito. Quando si entra nel campo rom per vedere, per conoscere bene la
situazione, occorre superare l’autorità esercitata da ciò che si vede subito, a prima vista, e aprire gli occhi ad un secondo sguardo. Guardare il campo rom significa tradurlo, decifrarlo, per “accogliere” ciò che si può vedere solo aprendo le ciglia del cuore. Non è solo un’esperienza fisica dei sensi, ma un vero esercizio di sapienza.»
Dice don Virginio Colmegna, fondatore e presidente della Casa della carità di Milano, nella prefazione al volume: «In questo mondo vi è tanto inferno… eppure il fatto che il Figlio dell’Uomo vi è stato ed ha portato proprio lì il germe del paradiso mi fa comprendere il valore dello stare in mezzo, non per assorbire il senso di morte, ma per ridare la speranza di attraversare, di lasciare alle spalle questo stare in mezzo, nella periferia di abbandono, per poter ripensare alla risurrezione scendendo ogni giorno negli inferi. […] Quando essere nati in un campo nomadi o essere rom diventa un’infamia che marchia il singolo a prescindere dalla sua storia personale, noi vediamo crescere uno strisciante razzismo. Dobbiamo, invece, far respirare la bellezza della giustizia fraterna, rifuggendo dall’orribile fraintendimento che colloca la proclamazione della legalità come difesa di sicurezza contro qualcuno, come via carica di mentalità espulsiva. Per questo stiamo nel mezzo promuovendo una legalità, soffocata nei tanti inferni, soprattutto laddove la diversità è presupposto di inferiorità».
2/12/2009
|





 Permalink
Permalink Oppure
Oppure >>
>> Stampa
Stampa 19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00
19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00
 Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.
9,50 E.
Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.
9,50 E. 








 Feed RSS 0.91
Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3
Feed Atom 0.3
